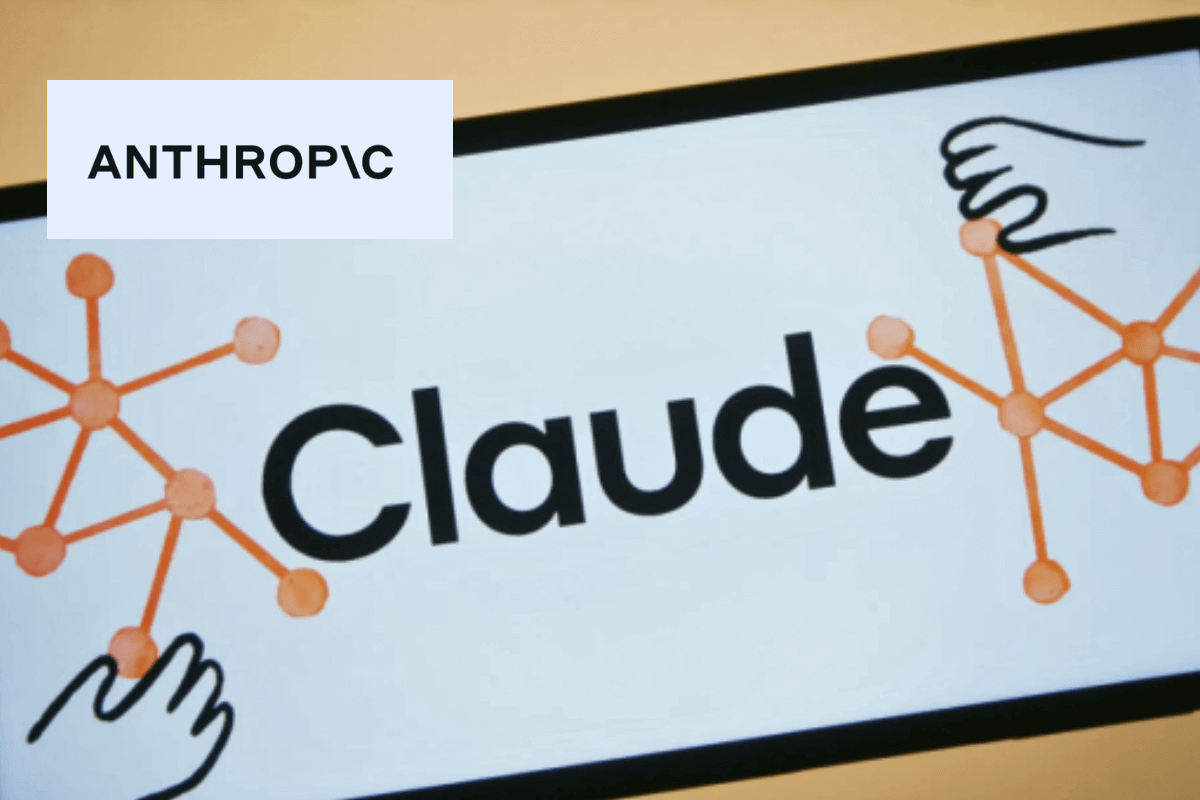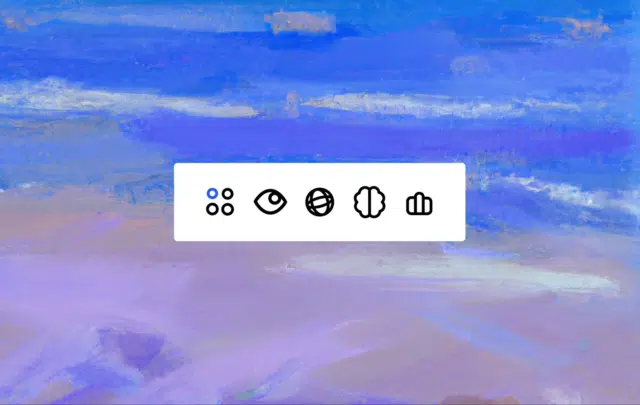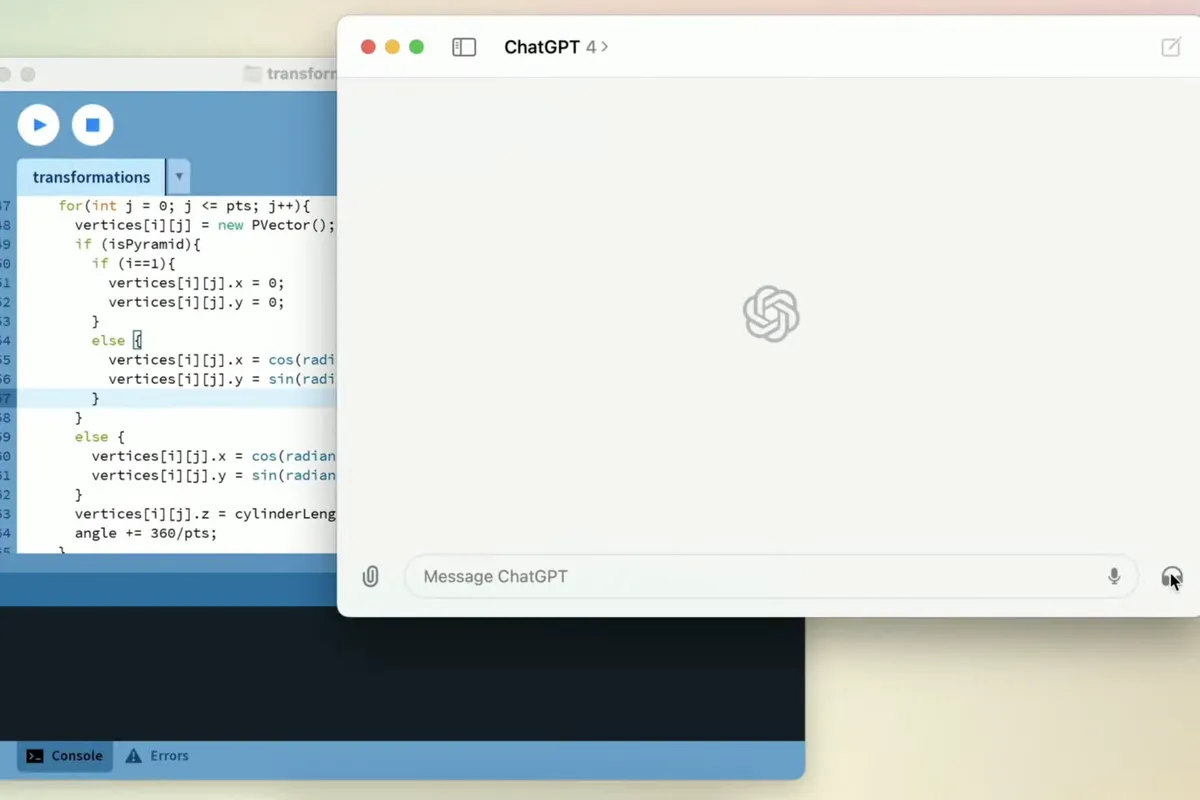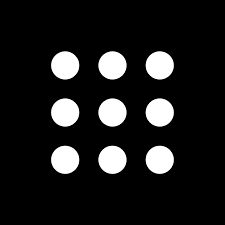Claude, l’Intelligenza Artificiale sviluppata da Anthropic, si sta rapidamente affermando come un punto di riferimento nel panorama tecnologico attuale. La sua capacità multimodale, unita a una potenza e precisione senza precedenti, promette di superare i giganti del settore come Gemini e ChatGPT. Il modello Claude 3 è stato progettato per affrontare una vasta gamma di domande, comprendere istruzioni complesse e fornire risultati precisi in tempo reale. Il fiore all’occhiello della famiglia, il modello Opus, ha dimostrato superiorità rispetto alla concorrenza in numerosi test di benchmarking, mettendo in luce le sue eccezionali capacità di ragionamento, risoluzione dei problemi e scrittura di codice.
Claude è finalmente disponibile anche in Europa! Ora, è possibile interagire con Claude, il chatbot di Anthropic, direttamente dal web o tramite l’applicazione disponibile su iOS. Una comodità senza precedenti!
nthropic ha annunciato l’offerta di piani di abbonamento particolarmente allettanti per gli utenti europei. Con soli 18 euro al mese, più IVA, è possibile accedere a tutte le funzionalità di Claude Pro, incluso il rinomato Claude 3 Opus, uno dei modelli più avanzati sul mercato. Per chi invece preferisce il lavoro di squadra, c’è il piano Team a 28 euro al mese a testa (IVA inclusa), con un minimo di cinque membri.
“… abbiamo messo tutto il nostro impegno per garantire che Claude sia preciso, sicuro e rispetti la privacy degli utenti”, ha dichiarato Dario Amodei, CEO e cofondatore di Anthropic.
Inoltre da oggi Claude parla anche italiano! Oltre al francese, al tedesco, allo spagnolo e ad altre lingue europee, ora è possibile comunicare tranquillamente con Claude nella propria lingua madre.
E per coloro che temono di non essere esperti tecnici, Anthropic ha reso l’interfaccia di Claude così intuitiva che chiunque può integrare i suoi modelli di Intelligenza Artificiale nei propri flussi di lavoro senza troppi problemi. Un vero vantaggio!
Anthropic ha rapidamente conquistato il cuore degli investitori nel mondo dell’Intelligenza Artificiale generativa. A marzo, sono stati investiti ben 18,4 miliardi di dollari per sostenere la crescita dell’azienda. Amazon ha contribuito con 4 miliardi di dollari, ma non è stato l’unico colosso a puntare su Anthropic; anche Google ha deciso di investire nella società.
Tuttavia, non mancano le attenzioni da parte delle autorità di regolamentazione. La Federal Trade Commission (FTC) statunitense ha aperto un’inchiesta sugli investimenti di Alphabet, Amazon e Microsoft nelle società Anthropic e OpenAI, segnalando un interesse crescente verso queste aziende specializzate nel settore dell’Intelligenza Artificiale. Sicuramente, c’è molto da monitorare in futuro!