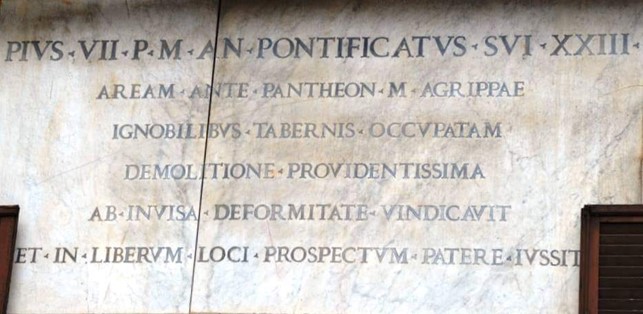Le catacombe sono forse i luoghi archeologici sui quali sono nate il maggior numero di storie e leggende: è molto diffusa, ad esempio, l’idea che fossero dei rifugi, per sfuggire alle persecuzioni, e che in questi sotterranei si svolgessero delle riunioni segrete, basta pensare alle sequenze di film famosissimi…
In realtà non erano affatto dei luoghi segreti: le autorità romane sapevano benissimo dove si trovavano le catacombe, inoltre, per quanto ne sappiamo, qui i Cristiani non si riunivano affatto come dei partigiani, ma venivano alla spicciolata, unicamente per pregare i loro morti.
C’è un altro mito da sfatare, e cioè che le catacombe erano tutte collegate tra loro, creando una specie di gigantesca rete sotterranea. In realtà non potevano superare i confini delle proprietà nelle quali erano state scavate, e in questo, le leggi romane erano severissime. Proprio per questo si svilupparono in verticale, su più piani, un po’ come le miniere, a volte anche per venti metri, cioè quanto un edificio di sei piani, come, ad esempio, nelle Catacombe di Priscilla.Le catacombe non erano altro che cimiteri, e il nome di ogni catacomba deriva dal martire sepolto, o dal nome del proprietario che aveva donato il terreno sotto al quale veniva successivamente scavata.
Nell’immaginario collettivo le catacombe non sono altro che una serie infinita di loculi scavati nel tufo, attraversati da corridoi molto stretti e bui, ma in realtà (purtroppo) questo è il risultato di una serie di devastazioni avvenute in epoche successive, soprattutto a cavallo tra il 1500 e il 1700, quando si aprivano le tombe per cercare le ossa dei martiri.
I defunti venivano inumati nelle nicchie che poi venivano richiuse con delle lastre di marmo, o, molto più spesso, con delle tegole e, a volte, in un solo corridoio trovavano posto più di cinquecento tombe.
Non è vero che i corridoi fossero bui, venivano illuminati da una miriade di lucerne posate su dei piccoli davanzai, ancora oggi se ne trovano molte sigillate nella malta. Sulle lastre, a volte, si leggono ancora i nomi, ma è raro: solitamente i morti erano seppelliti senza iscrizioni, e questo perchè all’epoca c’era moltissimo analfabetismo. Così per riconoscere il loculo del proprio defunto, i parenti fissavano nell’intonaco ancora fresco, degli oggetti: piccole conchiglie o pezzi di vetro colorati.
A volte sulle lastre tombali c’erano delle forature, che servivano a far passare del cibo all’interno della tomba: era il cosiddetto “refrigerium”, cioè un rito che consisteva nel banchettare assieme al defunto il giorno dell’anniversario della sua morte…in questi riti c’era ancora un po’ di paganità.
Le catacombe nacquero nel II secolo d.C.
Inizialmente si sfruttarono delle cave abbandonate di tufo, delle cisterne, ma poi, in seguito, le catacombe vennero scavate con una straordinaria precisione ingegneristica: i soffitti erano altissimi e le pareti rettilinee. Gli autori di queste gallerie erano i “fossori”, si tramandavano la professione di padre in figlio, e gestivano tutte le catacombe: erano loro che scavavano i corridoi, scavavano i loculi, inumavano i morti, dipingevano gli affreschi e scrivevano i nomi (dietro lauto compenso, ovviamente)
Si sa di casi in cui accettavano mazzette per sostituire delle salme nei punti più ambiti, magari vicino alle tombe dei martiri, o anche rivendevano più volte la stessa tomba.La paura di essere traslati era tale, che molti specificavano addirittura sulla lastra tombale, di essere i legittimi proprietari. Non tutti però venivano messi nei loculi, chi se lo poteva permettere, aveva un proprio sarcofago. C’era anche chi aveva delle cappelle, che si trovano un po’ ovunque, disseminate in questi corridoi,e qui però, è tutto un tripudio di affreschi molto belli, e hanno mantenuto i loro colori fino ai giorni nostri.
Nelle pitture che si trovano all’interno delle cappelle ci sono anche delle piccole sorprese: ad esempio nelle Catacombe di Priscilla c’è una Madonna con il Bambino considerata la più antica che si conosca, ha quasi 2000 anni ed è un piccolo capolavoro dell’antichità, anche se è in parte danneggiato.
Con le prime incursioni barbariche nel V secolo d.C. le catacombe cominciarono ad essere gradualmente abbandonate, e le salme dei martiri vennero traslate in luoghi più protetti.