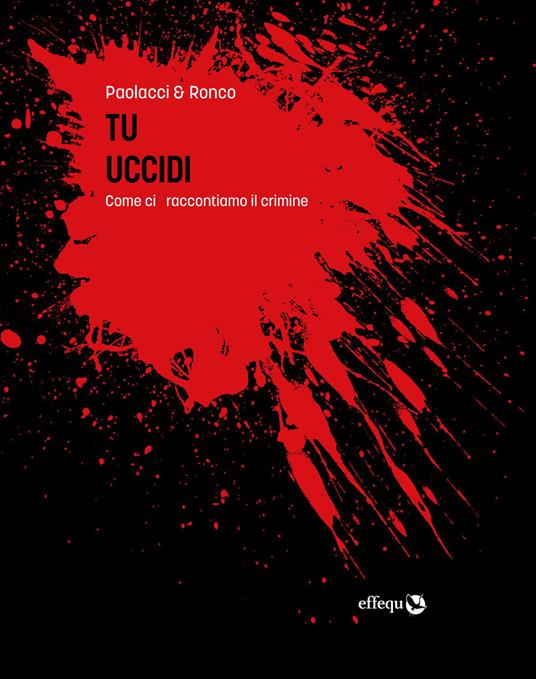Nel 1997, un giovane giapponese accende la TV e si ritrova davanti a una scena surreale: la maglia della Sampdoria indossata dai cattivi di una serie TV di supereroi.
Cos’è successo? Come è possibile che la squadra italiana sia finita in un telefilm nipponico?
La risposta ci porta nel mondo di Denji Sentai Megaranger, la 21esima serie di Super Sentai, franchise da cui hanno origine i Power Rangers. Nell’episodio 34, intitolato “Ti farò vedere il tiro miracoloso del fratellone!”, Shinji, un ragazzino che sogna di giocare a calcio come il fratello maggiore Koichiro (un Megaranger), viene umiliato dal suo allenatore e dai compagni. Disperato, si rivolge a Koichiro, che però, impegnato a salvare il mondo dai cattivi alieni, non può aiutarlo.
Shinji viene quindi circuito dal Porcospino Nejira, un malvagio allenatore che trasforma i suoi calciatori in armi umane usando le loro maglie della Sampdoria. La scelta della maglia blucerchiata non è casuale: in quegli anni, la Serie A era il campionato più seguito in Giappone, e la Sampdoria, con la sua divisa riconoscibile e i suoi giocatori iconici come Roberto Mancini, era una delle squadre più amate.
Tuttavia, la scelta di far indossare la maglia della Sampdoria ai cattivi potrebbe essere stata influenzata anche da motivi più banali. Lo sponsor tecnico della squadra era Asics, un marchio giapponese, e quindi la maglia potrebbe essere stata semplicemente la più facilmente reperibile.
Nonostante l’aiuto del Porcospino Nejira, Shinji non riesce a conquistare il mondo con i suoi tiri potentissimi. A sconfiggere i cattivi ci pensa proprio Koichiro, con un tiro miracoloso che ricorda quello di Roberto Baggio.
La storia della Sampdoria e i Power Rangers è un aneddoto curioso e divertente che ci ricorda l’impatto globale del calcio italiano negli anni ’90. La Serie A era seguita con passione in tutto il mondo, e i suoi giocatori erano idoli per milioni di tifosi. E la Sampdoria, con la sua maglia iconica e la sua storia ricca di successi, era una delle squadre più amate e conosciute.
Oltre a questo episodio di Denji Sentai Megaranger, la Sampdoria è stata recentemente menzionata anche da Liu Cixin, autore del romanzo di fantascienza “Il problema dei 3 corpi”. Cixin ha raccontato di essersi ispirato alla sua esperienza da spettatore di un’amichevole tra Sampdoria e Cina giocata a Pechino nel 1994 per alcune idee del suo libro.
Questi episodi dimostrano come la Sampdoria abbia lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. La sua maglia blucerchiata è un simbolo riconoscibile e amato, che ha ispirato storie e immaginari anche in contesti lontani come il Giappone.