Lo Scoppio del Carro è una manifestazione della tradizione popolare laico-religiosa che si svolge la domenica di Pasqua nel centro di Firenze. Questa cerimonia risale addirittura ai lontani tempi della prima crociata, indetta per liberare il Santo Sepolcro dalle mani degli infedeli.
Nel 1097, al comando di Goffredo di Buglione, Duca della bassa Lorena, i crociati, il cui nome derivò dalla croce rossa cucita sulla spalla destra della tunica bianca che ricopriva l’armatura, partirono per la terra santa e nell’estate del 1099 posero l’assedio alla città di Gerusalemme che espugnarono il 15 luglio. Secondo la tradizione fu il fiorentino Pazzino de’ Pazzi a salire per primo sulle mura della città santa dove pose l’insegna bianca e vermiglia. Per questo atto di valore, Goffredo di Buglione gli donò tre schegge del Santo Sepolcro.
Rientrato a Firenze il 16 luglio 1101, il valoroso capitano fu festeggiatissimo ed accolto con solenni onori. Le tre pietre rimasero inizialmente conservate nel Palazzo dei Pazzi e quindi consegnate alla Chiesa di Santa Maria Sopra a Porta in Mercato Nuovo, poi ampliata e rinominata come chiesa di San Biagio fino a quando, nel 1785, questa fu soppressa. Dal 27 maggio di quell’anno le sacre reliquie vennero definitivamente trasferite nella vicina Chiesa di Santi Apostoli dove tuttora sono gelosamente conservate in un’apposita cripta.
Gli storici ci hanno tramandato che dopo la liberazione di Gerusalemme, nel giorno del Sabato Santo, i crociati si radunarono nella Chiesa della Resurrezione e, in devota preghiera, consegnarono a tutti il fuoco benedetto come simbolo di purificazione. A questa cerimonia risale l’usanza pasquale di distribuire il fuoco santo al popolo fiorentino. Difatti, dopo il ritorno di Pazzino, ogni Sabato Santo, i giovani di tutte le famiglie usavano recarsi nella cattedrale dove, al fuoco benedetto che ardeva, accendevano rispettivamente una fecellina (piccola torcia) per poi andare, in processione cantando laudi, per la città a portare la fiamma purificatrice in ogni focolare domestico. Il fuoco santo veniva acceso proprio con le scintille sprigionate dallo sfregamento delle tre schegge di pietra del Santo Sepolcro.
Con l’andar del tempo lo svolgimento della festa divenne sempre più articolato per cui venne introdotto l’uso di trasportare il fuoco santo con un carro dove, su un tripode, ardevano i carboni infuocati. Non si conosce quando, in sostituzione del tripode, si usarono i fuochi artificiali per lo “scoppio del carro” ma si ritiene che ciò risalga alla fine del trecento.
Alla famiglia Pazzi era affidata l’organizzazione del carro e l’onere delle relative spese. Il privilegio di questa antica famiglia cessò nel 1478, per una provvisione della Repubblica che cacciò i Pazzi dalla città a seguito della famosa congiura ordita da essi contro i Medici. I cospiratori vennero uccisi e la Signoria, per cancellare tutto ciò che era legato alla famiglia caduta in disgrazia, ordinò che non si facesse più lo scoppio del carro mantenendo solo, per tradizione, la distribuzione al popolo del fuoco benedetto, che doveva avvenire fra il Battistero e la Cattedrale.
I fiorentini, però, non gradirono l’abolizione spettacolare dello “scoppio” e cercarono con tutti i mezzi di far revocare la provvisione del governo della Repubblica, e ciò non tanto per rispetto verso la famiglia Pazzi ma perché non volevano che l’offerta del fuoco pasquale ritornasse ad essere effettuata alla maniera semplice usata anticamente, senza più la caratteristica e fragorosa cerimonia oramai divenuta una consuetudine. Pertanto la Signoria ordinò ai Consoli dell’Arte Maggiore di Calimala, amministratori del Battistero di San Giovanni, di provvedere ai futuri festeggiamenti così come si usava fare prima della congiura.
Nel 1494, scossa dalla predicazione di morale cristiana del frate domenicano Girolamo Savonarola, la città cacciò i Medici e un’altra provvisione governativa restituì alla famiglia de’ Pazzi i suoi antichi diritti e privilegi, compreso quello dell’organizzazione del carro del Sabato Santo. Questo carro era inizialmente molto più semplice di quello attuale, ed a causa delle deflagrazioni e delle vampate che sopportava ogni anno, a cerimonia avvenuta, doveva essere quasi del tutto ripristinato. Parve quindi giusto ai Pazzi allestirne uno molto più solido ed imponente che dovesse durare per sempre. Fu, dunque, costruito il grande carro del tipo “trionfale” a tre ripiani, che da secoli, se pur più volte restaurato (anche dopo la tragica alluvione dell’Arno del 1966), gode ottima salute.








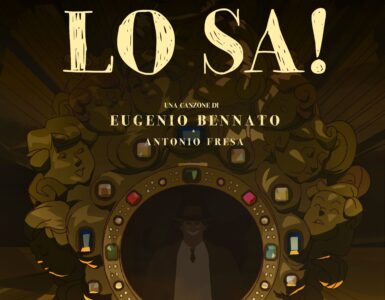










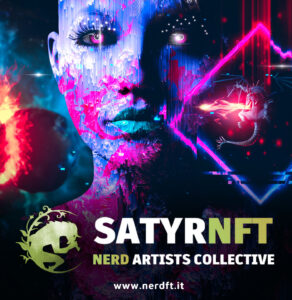





















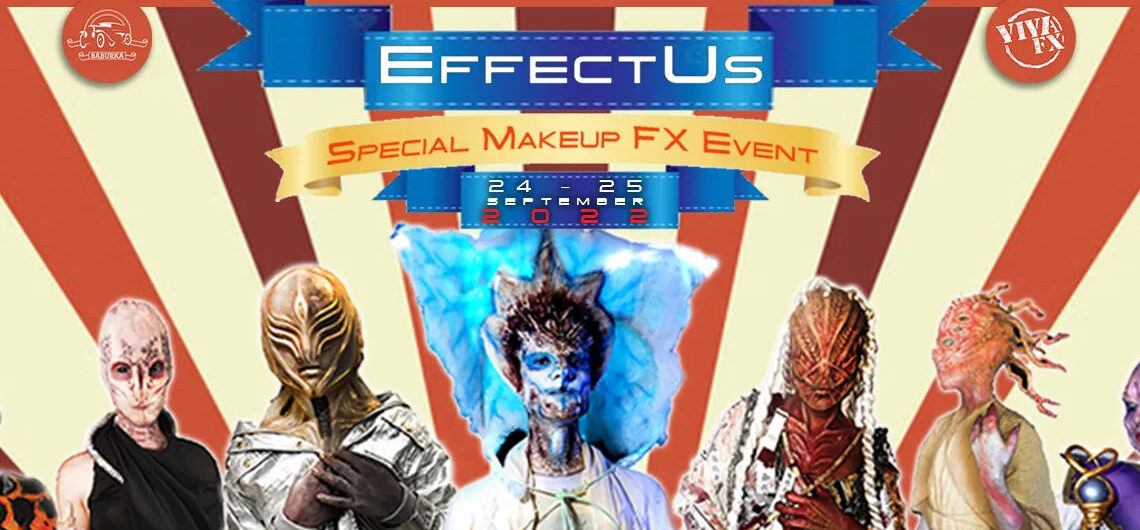

Aggiungi commento